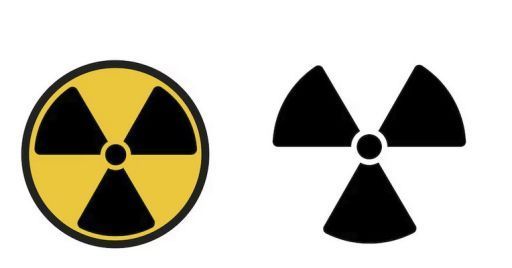
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Sicurezza nella medicina nucleare: la ventilazione e i requisiti dei locali
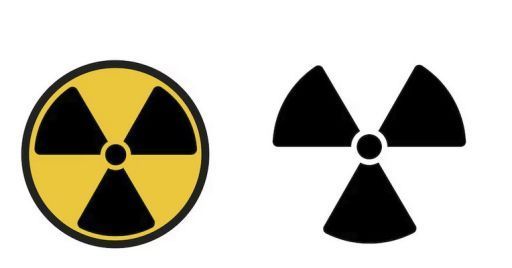
Roma, 30 Giu – In ambito sanitario, laddove si utilizzano radionuclidi per le applicazioni di medicina nucleare (MN), la sicurezza dipende anche dall’ambiente di lavoro, dalle tipologie di superfici e dal loro rivestimento.
Superfici e rivestimento sono infatti un “elemento di notevole importanza in fase di progettazione e allestimento delle aree di lavoro dove si manipolano sostanze radioattive e in generale di tutte le zone calde. Il pavimento e le superfici dei muri devono poter essere facilmente decontaminabili e, per quanto possibile, senza soluzione di continuità, e le finiture devono essere adeguate a quanto richiesto dalle norme di radioprotezione”.
A ricordarlo, in questi termini, è il documento “ Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci” che, realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’ Inail si è posto l’obiettivo di favorire il miglioramento delle strategie radioprotezionistiche tenendo conto anche degli obiettivi fissati dalla normativa (ad esempio, il d.lgs. 101/2020 per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti).
Per presentare quanto indicato dal documento Inail sui requisiti dei locali ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- La sicurezza nella medicina nucleare: pavimenti, pareti e superfici
- La sicurezza nella medicina nucleare: impianto di ventilazione
La sicurezza nella medicina nucleare: pavimenti, pareti e superfici
Riguardo alle pareti, superfici e altre infrastrutture, il capitolo “Caratteristiche e requisiti dei locali e degli impianti” indica che la giuntura del pavimento con i muri “deve essere arrotondata, con risalita sulle pareti di circa 20 cm, così da evitare angoli e asperità. L’intero rivestimento del pavimento deve essere impermeabile e facilmente decontaminabile”.
Il pavimento dei locali di lavoro “deve essere dunque costituito da materiale liscio, senza interstizi, rugosità o imperfezioni che possano intrappolare il contaminante, ad esempio da fogli di materiale plastico saldati fra loro e incollati al pavimento”.
Si indica poi che:
- “le piastrelle “non sono raccomandate a causa della possibilità di accumulo di contaminazione radioattiva nelle fughe.
- i materiali devono essere scelti anche tenendo conto della loro resistenza alla corrosione da parte di agenti chimici eventualmente utilizzati.
- i fogli di PVC non pigmentato o plastificato sono più resistenti alla contaminazione e più facilmente decontaminabili di quelli di altro materiale”.
È comunque buona regola – continua il documento – “rinnovare frequentemente tali rivestimenti”.
Inoltre:
- “le pareti possono essere, in alternativa ai fogli di PVC, ricoperte anche da vernici lavabili (vernici epossidiche, smalto o clorocaucciù) non porose, resistenti ai reagenti chimici e alle azioni meccaniche.
- le superfici di lavoro, dove sono usati o conservati radionuclidi (banchi e tavoli), nonché le sedie, devono essere rifinite con materiale duro, non poroso, impermeabile, lavabile e resistente al calore, alle macchie e alle sostanze chimiche, prediligendo l’utilizzo di grandi fogli e, quindi, di un numero minimo di raccordi”.
- è opportuno che “i bordi siano rialzati onde evitare sversamenti in caso di contaminazione. A tal fine è consigliabile l’utilizzo di acciaio inox”.
Si consiglia poi l’utilizzo di “pattumiere schermate nei luoghi di produzione di rifiuti radioattivi, quando valutato appropriato dall’ERP” ( esperto di radioprotezione). E la pulizia dei locali e delle superfici “deve avvenire regolarmente secondo procedure adeguate, che garantiscano la sanificazione e, se le circostanze lo richiedono, la sanitizzazione dell’ambiente. Tubature e canaline passa-cavi devono essere rivestite in modo da facilitare la pulizia e l’eventuale decontaminazione”.
Rimandiamo al documento che riporta indicazioni specifiche relative a:
- produzione di radiofarmaci con ciclotrone
- terapia medico-nucleare
La sicurezza nella medicina nucleare: impianto di ventilazione
Il capitolo indica poi che l’impianto di ventilazione ha un “ruolo fondamentale nella gestione e minimizzazione dei rischi sia di contaminazione radioattiva del personale e dell’ambiente, sia di contaminazione microbiologica dei prodotti radiofarmaceutici da parte del personale e dell’ambiente esterno”.
In particolare, si indica che l’aria immessa all’interno delle Unità Operative (UO) di Medicina nucleare (MN) deve essere condizionata attraverso un impianto che “permetta di ottenere un numero di ricambi aria in funzione dell’attività svolta e adeguate condizioni di temperatura e umidità relativa, in modo da garantire condizioni lavorative appropriate e il corretto funzionamento dei macchinari presenti”.
Si indica anche che l’impianto di ventilazione deve essere “separato dagli altri analoghi impianti dell’ospedale”. E nelle zone calde “devono essere installati sistemi di aspirazione e filtrazione dell’aria, con una logica di pressione differenziata fra i locali in funzione della classificazione e del livello di rischio”.
Dunque – continua il documento Inail - l’impianto di ventilazione deve “prevenire la diffusione dell’aria eventualmente contaminata da un locale all’altro all’interno dell’edificio mediante la logica dei gradienti di pressione (non deve inoltre prevedere il sistema di ricircolo) e deve ridurre la concentrazione di radioattività nell’aria di un ambiente potenzialmente contaminato attraverso un adeguato numero di ricambi aria”.
Si ricorda che le caratteristiche dei gradienti di pressione degli ambienti “devono essere conformi ai requisiti di radioprotezione e allo stesso tempo, ove richiesto, tali da proteggere la preparazione del radiofarmaco dalla contaminazione. L’aria immessa all’interno dei locali deve essere, inoltre, opportunamente filtrata per ridurre il carico di polvere e limitare così la potenziale risospensione di particolato contaminato e, se possibile, il flusso deve essere diretto preferibilmente verso il basso”.
Inoltre l’aria deve essere espulsa all’esterno “attraverso filtri ad alta efficienza appropriati alla natura e alla quantità dell’effluente”. Il condotto di esalazione deve essere poi “separato rispetto al normale condotto di esalazione dell’edificio e la presa esterna deve essere, chiaramente, ubicata in modo da evitare il ricircolo dell’aria di scarico. Il motore del ventilatore deve essere posizionato all’esterno del condotto al fine di evitare ogni possibile contaminazione e facilitarne la manutenzione”.
Il documento segnala la normativa tecnica di riferimento e si sofferma, ad esempio, sulla norma UNI 10491:1995 che prevede la “suddivisione dei reparti o laboratori all’interno dei quali vengono manipolate sorgenti radioattive non sigillate in 4 zone differenziate: A, B, C e D in relazione ai livelli di irradiazione e/o contaminazione crescenti da A verso D e alle condizioni di lavoro”.
Riprendiamo dal documento una tabella relativa ai valori di ricambi d’aria:

Si segnala che, come indicazione generale, in un’Unità Operativa di “diagnostica e terapia radiometabolica (in quest’ultimo caso ad esempio qualora sia dedicata al ricovero di pazienti trattati con 131I) si verificano le condizioni tipiche delle zone A, B, C, dove solitamente la camera calda e le stanze di degenza sono classificate come zona C. In ogni caso queste valutazioni, di competenza dell’ERP, devono considerare anche casi specifici come, ad esempio, degenze protette in cui si impiega solo 177Lu o 90Y”.
E per quanto riguarda invece il laboratorio di radiofarmacia, “nel caso in cui l’attività di manipolazione avvenga all’interno di celle calde, le stesse devono essere considerate zona D ai sensi della classificazione UNI 10491:1995, mentre il locale circostante può essere classificato come zona a rischio inferiore”.
Il documento riporta poi molti altri dettagli sulla ventilazione, ad esempio sui requisiti minimi per le stanze di degenza protetta, soffermandosi in particolare su ambienti e attività specifiche (laboratorio di radiofarmacia, produzione di radiofarmaci con ciclotrone, terapia medico-nucleare, …).
In conclusione, rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail e, in particolare, del capitolo che si sofferma anche sui sistemi di sicurezza e controllo e sulle schermature.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci”, Indicazioni operative aggiornate e integrate per la conformità al d.lgs. 101/2020, a cura di Maria Antonietta D’Avanzo, Massimo Mattozzi e Francesco Campanella (Inail – Dimeila), Gian Marco Contessa e Sandro Sandri (Enea), Stefano Adamo De Crescenzo (Istituto europeo di oncologia), Luca Indovina (Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli IRCCS) e Gian Luca Poli (ASST Papa Giovanni XXIII), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2022 (formato PDF, 1.97 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La progettazione e la sicurezza negli ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci”.
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'



